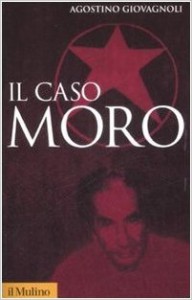 L’ossessiva insistenza sui misteri, gli «eccessi dietrologici», l’uso improprio della teoria del «doppio Stato» hanno trasformato il cinquantennio repubblicano in un susseguirsi d’episodi delittuosi, una «sorta di storia criminale da cui è mancata proprio la storia».
L’ossessiva insistenza sui misteri, gli «eccessi dietrologici», l’uso improprio della teoria del «doppio Stato» hanno trasformato il cinquantennio repubblicano in un susseguirsi d’episodi delittuosi, una «sorta di storia criminale da cui è mancata proprio la storia».
Dietro l’ostinata ricerca di protagonisti invisibili si sono persi di vista quelli realmente esistiti. È questo l’incipit con il quale lo storico Agostino Giovagnoli introduce il più recente lavoro sul sequestro del presidente della Dc, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana.
Un volume che dimostra come gli studi sugli anni 70 improntati ad una seria metodologia storica, seppur con fatica, stianno finalmente cominciando a farsi strada, dopo il pionieristico saggio sulla presunta “Pazzia” del presidente Dc, dato alle stampe da Marco Clementi nel 2001.
Allora venne posta per la prima volta la necessità di tornare a «fare storia», affrontando la vicenda del rapimento secondo una rigorosa metodologia che abbandonasse l’approccio deduttivo e indiziario, dietrologico, a vantaggio di un’analisi critica, di un confronto sincronico delle fonti originali (documentazione prodotta dalle Br e dal prigioniero).
Un contributo innovativo seguito più tardi dal lavoro di critica delle tesi del complotto realizzato da Vladimiro Satta, nel quale veniva definitivamente liquidata l’imponente pubblicistica sulla cospirazione.
Avviato il percorso metodologico sui binari di una seria critica storica è finalmente possibile raffrontare anche le diverse letture sin qui esposte.
Al pari di Clementi anche il lavoro di Giovagnoli segue la prospettiva di una «storia politica» del rapimento, ma se ne distacca subito perché incentrata essenzialmente su quanto accadde nel mondo delle istituzioni e dei partiti, grazie ad una indagine condotta negli archivi di diverse fondazioni e istituti.
La sua è una storia vista dal Palazzo e l’obiettivo è dimostrare che, dopo un iniziale irrigidimento attorno alla linea della fermezza, il clima cominciò a cambiare aprendo margini di manovra «tattici» che consentissero una soluzione negoziata. In sostanza, spiega l’autore, tentativi vennero fatti, aperture non mancarono, offerte furono avanzate, ma alle Brigate rosse tutto questo non bastò.
È a loro, e solo ai loro limiti politici ed alla loro intransigenza, che si deve la morte di Moro. In fondo la tesi del libro è tutta raccolta in questo enunciato: ancora poche ore e quel 9 maggio 1978 il gruppo dirigente Dc avrebbe pronunciato la parola «forte», chiesta per liberare l’ostaggio nel famoso comunicato del gerundio (che serviva a dilazionare ulteriormente l’esecuzione) e nell’ultima telefonata di Moretti.
Ora se è evidente che a rapire ed uccidere Moro furono le Br, le quali hanno sempre assunto l’intera responsabilità politica e materiale della scelta fatta, è altrettanto vero che a quell’esito contribuirono in molti, come emerge anche dal racconto di Giovagnoli, nonostante l’evidente tentativo di attenuare, se non addirittura assolvere, le responsabilità del «fronte della fermezza».
Lo sforzo diretto a lenire le responsabilità etiche che in quella vicenda ebbe il ceto politico-istituzionale non trova prove né argomenti persuasivi ed a volte scade persino nel grottesco, come quando viene messo l’accento su un Andreotti apostolo della nonviolenza (p. 50). Basterebbe rileggere quel che Moro scrisse di lui nel Memoriale per smentire un quadro così idilliaco.
Non si tratta di convocare gli anni 70 «sotto un’unica chiamata di correità», per cercare «balsami» ad una memoria funzionale ad un «discorso retrospettivo insieme cinico e zuccheroso, che nel nome di una sospirata riconciliazione nazionale tende a confondere carnefici, vittime, spettatori», come ha scritto Sergio Luzzato nella recensione apparsa sul Corriere della Sera.
La rimozione e l’autoindulgenza è abitudine rassicurante ma poco lungimirante. Troppo facile ridurre ogni cosa alla «lotta senza quartiere di un gruppo criminale numericamente striminzito, ideologicamente povero e moralmente abietto»: il bene da una parte e il male dall’altra.
La mattina del 16 marzo 1978, diverse agenzie avevano associato il nome di Moro a quello dell’«antilope Kobbler», il mai identificato collettore delle tangenti Lockeed. Il riferimento scomparve dalle edizioni speciali dei quotidiani non appena si diffuse la notizia del rapimento, sostituita da ipocriti ritratti che suonavano già come coccodrilli a futura memoria.
L’illibatezza etica è l’ultima delle virtù che può essere rintracciata in quello che fu il fronte del rigor mortis, paralizzato non meno dei militanti Br da limiti politici e culturali, pregiudizi e fantasmi, ricatti e ipnosi reciproche. Si tratta invece di capire come sono andate le cose rifuggendo la facile tentazione di attribuire ogni colpa agli sconfitti.
Per esempio, perché ci si ostina ancora a non voler vedere – come ha osservato Clementi – le impressionanti analogie col sequestro Sossi, eccezion fatta per le modalità incruente che certo contribuirono a non pregiudicarne il seguito? In passato si era trattato e si continuò a farlo dopo Moro. Il mancato negoziato è dunque una delle poche responsabilità attribuibili ai brigatisti, che pure commisero notevoli ingenuità – come rendere pubblica la lettera riservata che Moro aveva scritto a Cossiga – a causa dell’inadeguatezza teorica e dell’abissale distanza dai bizantinismi di un Palazzo che combattevano ma ben poco comprendevano.
Negli oltre 50 giorni di sequestro non ci fu uno straccio d’iniziativa politica seria: il vertice democristiano restò immobile e incapace di sviluppare una minima analisi della situazione, come testimoniano i diari di Fanfani. Le lettere di Moro furono rinviate al mittente, decretato «pazzo». Il Pci ne dichiarò la morte anzi tempo, come Pecchioli disse a Cossiga. Le ipotesi più astruse e improbabili vennero privilegiate a discapito delle evidenze. Solo Moro capì cosa erano e volevano le Br, ma dalle Br stesse fu soppresso, decretando insieme alla morte dell’ostaggio anche la loro fine strategica. Uccidendo il presidente Dc liquidarono l’unica risorsa rimasta nelle loro mani dopo un sequestro concepito male e finito peggio.
Non c’era stata l’auspicata rottura tra base e vertice Pci, non c’era stato nessuno spostamento a sinistra, al contrario un’integrazione ancora più forte del Pci nello Stato. L’obiettivo principale era fallito e nessuna ipotesi alternativa era stata predisposta. A quel punto una via d’uscita avrebbe potuto essere la liberazione del prigioniero, prevalse invece un super io morale: impossibile salvare la vita del Principe senza contropartite, dopo aver distrutto quella dei suoi scudieri. Si sarebbero esposti alla facile retorica di chi nella sinistra poteva accusarli di magnanimità verso il potere mentre facevano strage dei «proletari in divisa».
Così uccidendo l’ostaggio entrarono in una contraddizione etico-politica insanabile: come giustificare l’esecuzione del proprio prigioniero quando al tempo stesso si chiedeva la liberazione di quelli in mano all’avversario?
La «geometrica potenza» del successo militare servì solo a dopare il fallimento dell’iniziativa. Il rafforzamento organizzativo che ne seguì fece da schermo ad una realtà senza più prospettive politiche se non l’estensione e l’intensificazione aritmetica del volume di fuoco.
Il rifiuto della trattativa è questione storiografica complessa e forse costituisce l’aspetto più importante dell’intera vicenda. Essa rinvia ad un enorme rimosso che non trova soluzione nel libro di Giovagnoli. La natura inconfessabile del conflitto che traversò gli anni 70 rimane ancora un tabù insuperato. L’indisponibilità a riconoscere non tanto la valenza politica delle Br quanto ad intravedere quel che si profilava alle loro spalle, ovvero radici e dimensioni di una sovversione politica scaturita dalla crisi di modello e delle forme di rappresentanza che stavano minando la vecchia società fordista, spiega l’arroccamento nella cittadella della fermezza.
La società del rigor mortis, sconcertata dalle nuove forme di protagonismo, di partecipazione e da richieste percepite come incompatibili ed esorbitanti, vedeva in quell’insorgenza sovversiva – che aveva radici nell’irruenza dei movimenti sociali di quegli anni – una minaccia intollerabile. Altrove si era riusciti ad assorbire l’onda d’urto, gli Stati avevano sempre trattato con le guerriglie, come ricordava Moro nelle sue lettere. Nell’Italia imbalsamata dai vincoli geopolitici e dai patti consociativi prevalse invece l’intransigenza cimiteriale dell’unità nazionale.
Liberato Moro «le Br avrebbero cessato di sparare. Un’altra storia sarebbe cominciata» ha dichiarato Moretti in un libro. Cosa mai avrebbe avuto di trascendentale un simile scenario?
Su sponde opposte, uno studioso come Federico Mancini arrivò ad ipotizzare un processo di costituzionalizzazione dell’area sociale sovversiva, convinto che la fissità del sistema italiano, impedendo innovazione politica e rinnovamento sociale, col tempo non avrebbe potuto evitare insorgenze e spinte sovversive. Allora trent’anni più tardi piuttosto che cercare il male nella storia sarebbe più utile interrogare limiti e contraddizioni della società che prese forma nel dopo guerra, e che negli anni 70 raggiunse il suo punto di rottura.
Paolo Persichetti
